Il lato soggettivo del Tempo
4 min read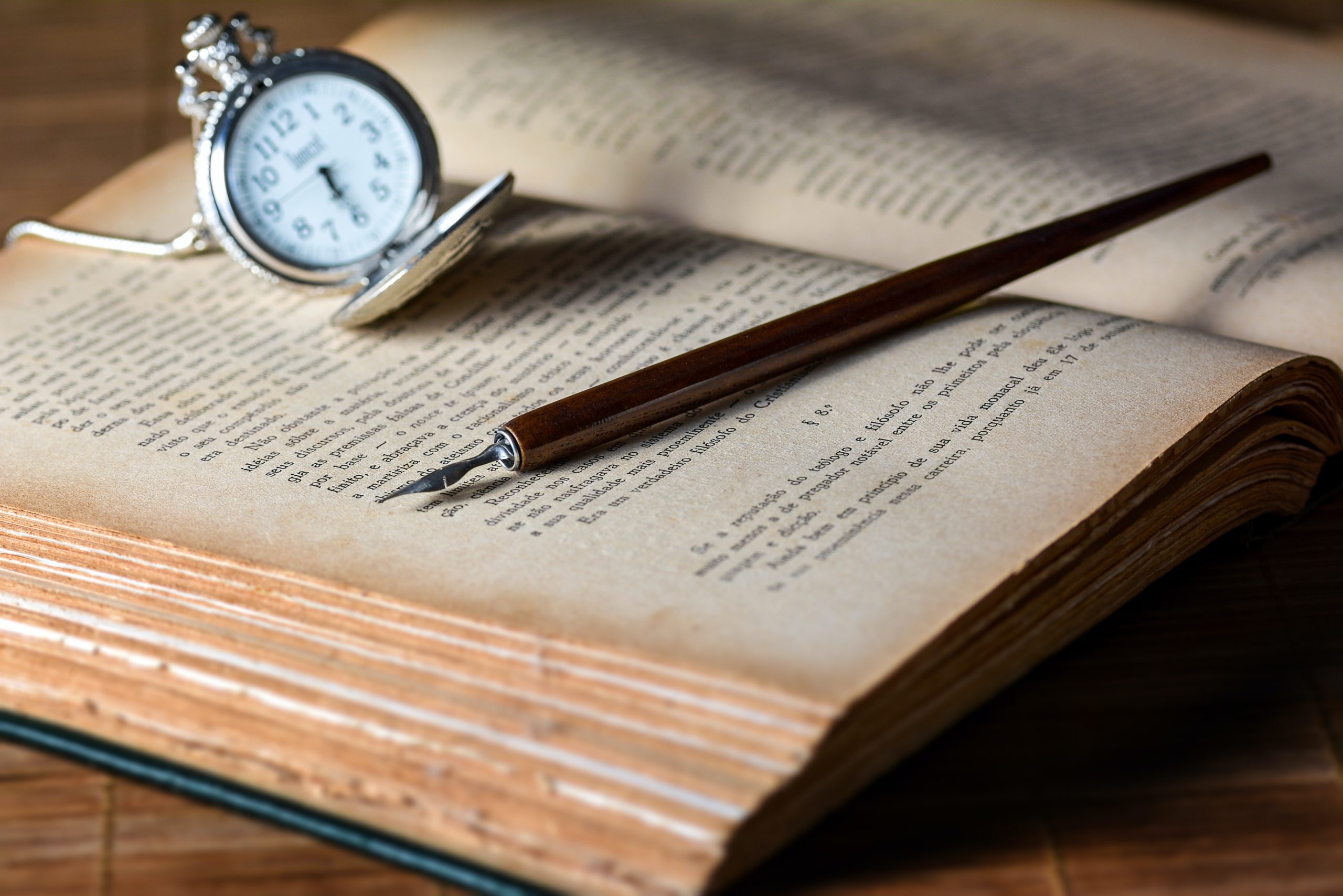
Tempo di lettura: 5 minuti
Nei decenni a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, l’uomo cominciava a mettere in discussione sé stesso e tutte quelle convinzioni che nei secoli precedenti fungevano da dogmi inconfutabili. Mentre il mondo progrediva nella scienza e nella tecnica, la realtà quotidiana si faceva sempre più complessa, rendendo gli uomini più partecipi e consapevoli delle sfaccettature della mente grazie, soprattutto, alla nascita della psicanalisi.
Uno degli ambiti la cui concezione subì, all’epoca, degli enormi stravolgimenti fu il Tempo. L’idea che l’uomo aveva del Tempo era sempre stata oggettiva, cronologica, soggetta alla tirannia dell’orologio. Passato, presente e futuro percepiti come tre dimensioni separate, poste in successione lineare. E così rimase, finché il filosofo francese Henri Bergson non cambiò le carte in tavola. Nel suo Saggio sui dati immediati della coscienza (1889), Bergson divide il concetto di Tempo secondo due accezioni: il tempo omogeneo e la durata interiore, rispettivamente il tempo oggettivo, misurabile scientificamente, e il tempo percepito, esente da ogni metodo di misurazione. Contrastando così le correnti positiviste dell’epoca, Bergson inserisce nel mondo scientifico quell’elemento che, da sempre, era visto come il suo opposto: la soggettività.
La durata interiore altro non è se non il modo in cui la nostra mente percepisce lo scorrere del tempo, una percezione non soggetta a leggi fisiche, bensì agli stati d’animo e alla sfera emotiva di ognuno di noi. Una situazione spiacevole, di disagio o noia (un esame, un colloquio di lavoro, un viaggio in auto) ci sembra interminabile, in quanto gli stati d’animo negativi entrano in gioco dilatando la percezione temporale. Al contrario, in situazioni di felicità, euforia o serenità, il tempo sembra volare, scorrendo come sabbia tra le dita, e un’ora ci sembra durare solo cinque minuti. Emblematico è l’esempio della zolletta di zucchero che si scioglie in un bicchiere d’acqua: la scienza calcolerà il tempo esatto impiegato dalla zolletta per sciogliersi, che sarà uguale ed innegabile per qualsiasi altra zolletta in qualsiasi altro bicchiere; il tempo della coscienza, invece, farà percepire la durata in modo diverso in base allo stato d’animo dell’osservatore, se si trova, infatti, in una condizione di pace o d’insofferenza.
Il pensiero di Bergson aprì nuove possibilità specialmente al mondo delle arti, ispirando scrittori, pittori e registi nel tentativo di dare forma alla soggettività del Tempo. Tra gli esempi più famosi vi è, senza dubbio, la colossale opera autobiografica di Marcel Proust, Alla Ricerca del Tempo Perduto (1913-1927), in cui i ricordi del passato si dilatano a tal punto da assorbire il presente narrativo, immergendo il lettore in una dimensione passata ricca di dettagli, percezioni e sentimenti. Egli stesso scrisse “Un’ora, non è solo un’ora, è un vaso colmo di profumi, di suoni, di progetti, di climi.”. Come cerchi concentrici nell’acqua, infatti, le memorie di Proust si delineano a poco a poco, il tempo perduto viene recuperato pagina per pagina, andando a costituire quello che è ancora oggi il romanzo più lungo al mondo. Come potrebbe non esserlo, dopotutto, un romanzo sul Tempo, la memoria e l’esperienza umana?
I primi anni del Novecento furono un periodo ricco di scoperte e sperimentazioni, in cui Scienza ed Arte si influenzavano a vicenda. Basti pensare a quanto la Teoria della Relatività di Albert Einstein abbia condizionato i metodi d’espressione letteraria, artistica e cinematografica. In poche parole, Einstein affermava che fosse la velocità dell’osservatore ad influenzare la percezione dello scorrere del Tempo, e dunque la dimensione temporale non sarebbe più oggettiva, come invece affermava la fisica newtoniana. Quali conseguenze ebbe questa scoperta nelle arti? Semplice, la consapevolezza di molteplici e differenti punti di vista da soggetto a soggetto portò ad un distacco dalle convenzioni tradizionali che vedevano la realtà raffigurata da un solo sguardo, da un solo punto di vista.
Nel mondo della letteratura, in particolare, il riconoscimento di questa soggettività spaziotemporale portò allo sviluppo di tecniche letterarie come i flashback, la frammentazione narrativa, il flusso di coscienza, la simultaneità o il narratore inattendibile, ovvero tecniche che alterano la tradizionale struttura narrativa caratterizzata dalla descrizione lineare ed oggettiva degli eventi. Come abbiamo detto, la realtà e il pensiero degli uomini di fin de siècle si facevano di giorno in giorno sempre più complessi, e la letteratura cercava di seguire e riflettere questi cambiamenti. Per questo, scrittori come James Joyce e Virginia Woolf si spinsero oltre i limiti della sperimentazione, lasciando un segno indelebile nella letteratura a venire. Con il suo Mrs. Dalloway (1925), Virginia Woolf riuscì nell’intento di dare forma al concetto di simultaneità. Attraverso l’alternanza di monologhi interiori e narrazione onnisciente, il lettore entra ed esce in continuazione dalla mente dei personaggi, dalla sfera privata a quella pubblica. Elementi del mondo esterno come il rintocco del Big Ben vengono percepiti dai personaggi allo stesso momento, ma in modi diversi, suscitando ricordi o impressioni che si dilatano per pagine mentre la durata effettiva del rintocco dura solo pochi istanti. Con questo contrasto narrativo tra il tempo esterno e il tempo della mente, la Woolf diede una rappresentazione perfetta a ciò che Bergson intendeva per tempo omogeneo e durata interiore.
Il Tempo è una dimensione affascinante, e sebbene l’uomo vi sia circondato ed immerso da sempre, fatica ancora a capire interamente i misteri che lo caratterizzano. Tuttavia, dinanzi le oscurità di un elemento tanto incontrollabile ed intangibile, abbiamo dalla nostra parte la Scienza per poterne esplorare gli enigmi e l’Arte per provare a rappresentarli, tentando, attraverso libri, film o dipinti, di bloccare per qualche istante il suo incessante scorrere.

Sono laureata in Lingue e Letterature Straniere a Venezia, città da cui ho imparato l’attenzione ai dettagli nascosti dell’esistenza, nonché l’elogio della lentezza (come direbbe Kundera). Ho sempre visto la letteratura, l’arte, la musica e il cinema come i cardini fondamentali della mia vita, le cui correnti mi hanno reso la persona che sono oggi.





