Lavorare? Una questione di entropia
15 min read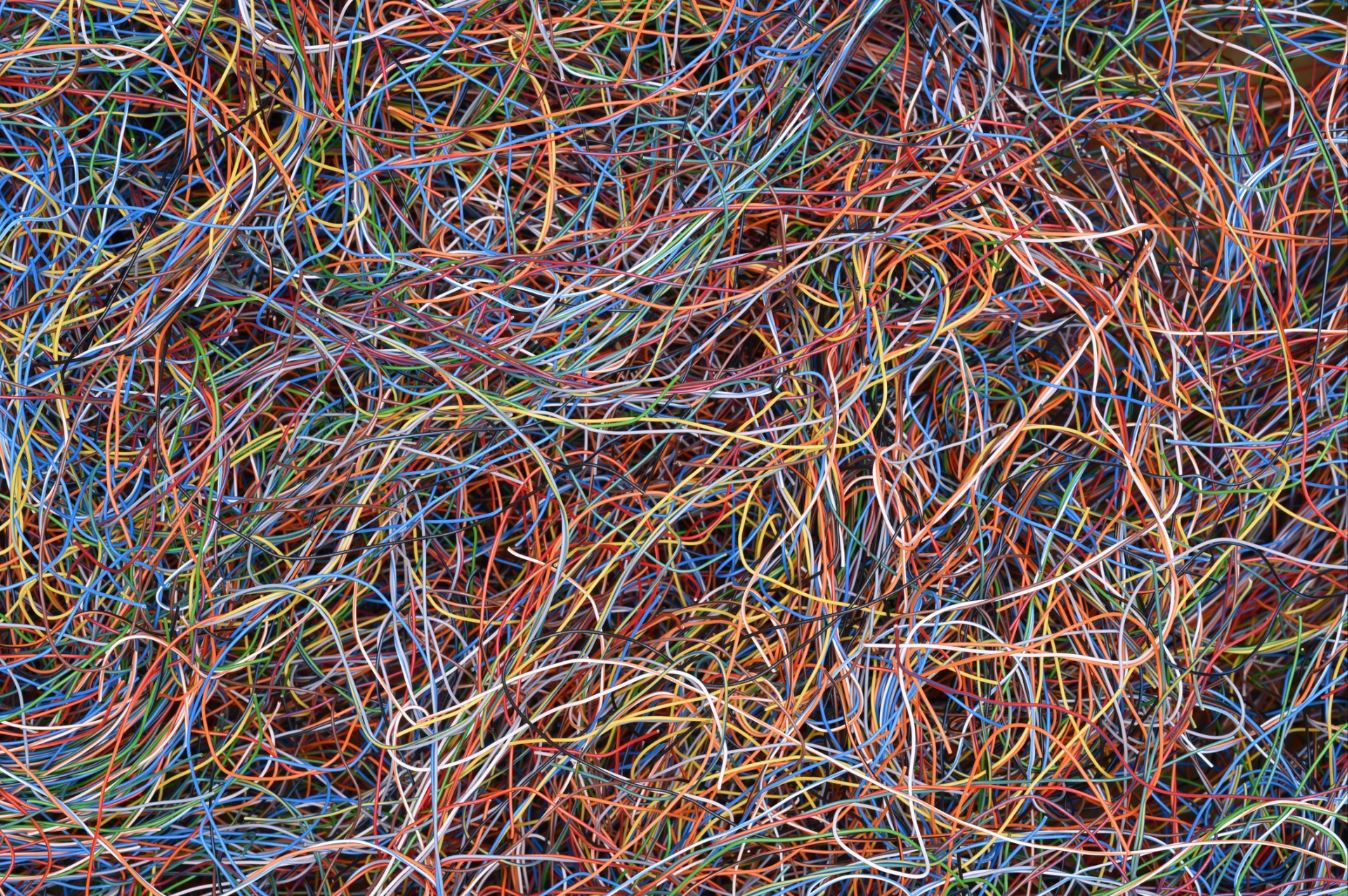
Dimmi cosa fai nella vita e ti dirò chi sei. Ci viene naturale cercare nella professione della persona che abbiamo davanti dettagli che ci aiutino a definire meglio chi è quell’individuo. In fondo, il lavoro a cui una persona si dedica può nascondere interessanti indizi sui valori, le storie personali o semplicemente gli interessi che quel tizio coltiva. Il connubio tra identità e professione affonda le proprie radici nel nostro passato più remoto. Non per niente i cognomi che ereditiamo dai nostri genitori, spesso di origine medioevale, contengono tracce della professione dei nostri avi, quando il lavoro di una persona era una caratteristica così distintiva da diventare la sua identità letterale per generazioni. Beccaria, ad esempio, origina dal termine beccaio con cui anticamente si indicava, in tempi remoti, la professione del macellaio.
È però nel ‘500, con l’affermarsi della dottrina calvinista, che la società occidentale sembra trovare una legittimazione incontestabile al proprio culto del lavoro. Origine di tutto è la teoria della predestinazione di Calvino, secondo cui il destino di ogni singolo essere umano è stabilito alla nascita. Si nasce già destinati alla salvezza oppure già dannati; a nulla possono servire le buone azioni che ognuno può compiere in vita per guadagnarsi l’accesso al Paradiso. Quindi, ci si potrebbe chiedere, a cosa serve impegnarsi duramente nella vita se tutto è già scritto? Calvino risponderebbe: “Per scorgere dei segnali”. A quale scopo? Beh, visto che l’essere umano è per natura curioso, va da sé che la curiosità del singolo possa spingerlo a cercare di individuare, tra le sue conoscenze, quegli individui che sono nati già predestinati alla salvezza. Ovviamente il tutto con un interesse ben più personale: magari per scoprire se nella lista c’è anche lui. Secondo Calvino si possono intercettare dei “segni” esteriori rivelatori del destino del singolo. Ad esempio, possono essere rintracciati nella bellezza prorompente di una persona o in un’abilità particolarmente sviluppata o nella capacità di avviare un’attività di successo. E’ questo uno degli indicatori più visibili della grazia divina: la ricchezza; una ricchezza generata dal lavoro.
Non a caso nella dottrina calvinista è presenta un’etica del lavoro molto profonda, basata sul concetto di Beruf, che in tedesco assume il significato di vocazione in senso religioso, ma che nella dottrina viene inteso soprattutto come vocazione professionale.
Secondo il sociologo Max Weber, il calvinismo introduce quindi l’idea della necessità di provare la propria fede nell’attività mondana. Come dire: è il lavoro e il tentativo di prosperare negli affari che dimostra all’individuo di essere tra gli eletti di Dio; un predestinato.
L’obiettivo della propria esistenza diventa, dunque, non il piacere derivante dall’impegno, ma l’impegno in sé stesso, alla ricerca di una continua quanto disperata attestazione di predestinazione. Chi non ce la fa si rivela agli occhi degli altri come un peccatore, un essere che Dio ha escluso dalla grazia. Un influenza forte, tanto più che, sempre secondo Weber, la rivoluzione industriale, non a caso, prese le mosse in Europa proprio in quei paesi sotto l’influenza calvinista.
Se quanto appena detto non bastasse a spiegare il nostro attuale rapporto con il lavoro, avvicinandoci un po’ di più ai nostri gironi, potremmo chiamare in causa la teoria economica classica e il cosiddetto problema fondamentale. Di cosa si tratta? Come tutti gli economisti sanno, il problema economico fondamentale emerge dall’inconciliabile relazione tra due fattori: desideri e risorse. Mentre i desideri dell’uomo sono per loro natura potenzialmente illimitati, i beni in grado di soddisfare questi desideri sono necessariamente limitati. Infatti, sia le risorse esistenti in natura, sia i beni producibili dall’uomo, sono in quantità limitata e non infinita. E’ il dilemma della scarsità. Come possiamo quindi soddisfare sempre più desideri con sempre meno risorse? Attraverso il lavoro, aumentando l’efficienza con cui le risorse disponibili vengo allocate. In che modo? Con lo sviluppo di nuove tecnologie produttive e con l’incremento della produttività dei lavoratori. Aumento della produttività che nella realtà si traduce quasi sempre in aumento delle ore lavorate.
Potremmo quindi aver già dato una risposta su quali siano le radici su cui si fonda la nostra attuale dipendenza dal lavoro. Una storia lunga, fatta di identità e ricerca di salvezza, rafforzata recentemente da una cultura che genera sempre più nuovi desideri da soddisfare, da cui diventiamo dipendenti. Nelle parole dell’economista controcorrente Galbraith: “Man mano che una società diventa più ricca, i desideri vengono creati sempre di più dal processo attraverso il quale vengono soddisfatti […]. I desideri diventano così dipendenti dalla produzione. In termini tecnici non si può più presumere che il benessere collettivo sia maggiore con un livello di produzione più elevato rispetto ad un livello inferiore. Una maggiore produzione è data semplicemente da un livello più alto di creazione dei desideri che a sua volta richiede un livello più alto di soddisfazione degli stessi. Questo processo prende il nome di Effetto Dipendenza.”
C’è un autore però, l’antropologo James Suzman, che nel suo ultimo libro ci mette di fronte ad un’ulteriore ipotesi: e se la nostra dipendenza dal lavoro fosse una questione di entropia? Bella questa! Sembrerebbe un’idea geniale, fatta apposta per attrarre visibilità e valanghe di LIKE sui social!
Ma invece l’idea poggia su solide argomentazioni.
Andiamo per ordine e cerchiamo di fare chiarezza.
Prima di tutto, per chi non è avvezzo con la materia, definiamo cosa si intende con il termine lavoro. Con lavoro si indica genericamente “l’applicazione di un’energia (umana, animale o meccanica) al conseguimento di un fine determinato”. Il concetto di lavoro è quindi legato indissolubilmente a quello di energia, tanto che se dovessimo definire il concetto di energia passeremo da quello di lavoro, ovvero: “l’energia è considerata l′ attitudine di un corpo o di un sistema a compiere lavoro”.
Aggiungiamo un altro pezzo al nostro puzzle. Occupiamoci adesso del concetto di entropia; qui le cose si fanno più complicate.
La termodinamica, ambito in cui si studia l’entropia, considera i sistemi reali non come semplici macchine meccaniche, ma come macchine termiche che trasformano l’energia da una forma ad un’altra. Una delle macchine termiche con cui abbiamo a che fare quotidianamente è il motore della nostra autovettura. Fornendogli energia termica sotto forma di carburante, il motore la trasforma in energia meccanica: quella rotazione che fa muovere le ruote del veicolo. Nel mondo reale tali trasformazioni sono tutte di tipo irreversibile: ovvero invertendo il processo per tornare allo stato iniziale ci accorgeremmo che qualcosa si è perso. In un processo irreversibile, quindi, non potremmo più ricostruire perfettamente lo stato iniziale da cui siamo partiti.
L’entropia è quella grandezza fisica che, in un sistema, misura la parte dell’energia che non può più essere utilizzata per compiere un lavoro e quindi viene persa, ovvero misura il degrado dell’energia disponibile in un sistema. Visto che in un qualsiasi sistema reale una piccola quantità di energia sarà sempre dissipata all’esterno, il valore dell’entropia tende sempre a crescere nel corso di un processo naturale. Quanto appena detto, in maniera molto sintetica, non è altro che una versione iper-semplificata del cosiddetto secondo principio della Termodinamica: ovvero che l’entropia nell’universo è in costante aumento. Ci dobbiamo preoccupare di questo? In parte, visto che l’aumento costante dell’entropia vuol dire che l’universo tende (come tutti gli altri sottosistemi) a una redistribuzione dell’energia tale da portare a uno stato “disordinato” della materia, “disordinato” ma in equilibrio inerte: tecnicamente detto morte termica.
E a noi esseri umani, cosa importa di tutto questo? Siamo anche noi macchine termiche e quindi dovremmo fare i conti con la stessa regola. In biologia lo stato di equilibrio inerte corrisponde alla morte. Va da se, che ogni organismo vivente, per poter funzionare, deve trovarsi al di fuori del suo stato di equilibrio. Poc’anzi ho usato il termine dovremmo, al condizionale, perché fortunatamente il secondo principio della termodinamica vale solo per sistemi cosiddetti chiusi e isolati. Sistemi che non scambiano né materia né energia con l’esterno. Cosa che gli esseri viventi non sono. E allora per noi qual è la regola? Ve lo faccio spiegare da un premio Nobel, Erwin Schroedinger; quello fissato con i gatti. Nel suo libro Che cos’è la vita il fisico scrive: ”Qual è l’aspetto caratteristico della vita? Quando è che noi diciamo che un pezzo di materia è vivente? Quando esso va facendo qualcosa, si muove, scambia materiali con l’ambiente e così via, e ciò per un periodo di tempo molto più lungo di quanto ci aspetteremmo in circostanze analoghe da un pezzo di materia inanimata”. Ovviamente non è tutto qui. Caratteristica distintiva dei sistemi viventi è anche quella di conservare un ordine interno: “ la vita sembra dipendere da un comportamento, ordinato e retto da leggi rigorose della materia, non basato esclusivamente sulla tendenza di questa a passare dall’ordine al disordine, ma basato in parte sulla conservazione dell’ordine esistente”.
Ma la conservazione di un ordine interno si scontra con la tendenza dei sistemi di andare verso un aumento costante del proprio disordine dovuto all’aumento inevitabile dell’entropia. Come risolvere il paradosso? “Come fa un organismo vivente a evitare questo decadimento (aumento dell’entropia)? La risposta ovvia è: mangiando, bevendo, respirando e (nel caso delle piante) assimilando. Il termine tecnico è metabolismo.
Il verbo greco corrispondente significa cambiare o scambiare. Scambio di che? Originariamente, l’idea contenuta nel termine era senza dubbio scambio di materiali […] Per un certo tempo, nel passato, la nostra curiosità fu soddisfatta dal sentirci dire che ci nutrivamo di energia. Qual è allora quel prezioso elemento contenuto nel nostro cibo che ci preserva dalla morte? A questa domanda si risponde facilmente. Ogni processo, evento, fenomeno, chiamatelo come volete, in una parola tutto ciò che avviene in natura, significa un aumento dell’entropia di quella parte del mondo ove il fatto si verifica. Così un organismo vivente aumenta continuamente la sua entropia, o, si può anche dire produce entropia positiva e così tende ad avvicinarsi allo stato pericoloso di entropia massima, che è la morte. Esso può tenersi lontano da tale stato, cioè in vita, solo traendo dal suo ambiente entropia negativa, […] si può dire che l’essenziale nel metabolismo è che l’organismo riesca a liberarsi di tutta l’entropia che non può non produrre nel corso della vita.” Ecco svelato quindi l’arcano: ogni organismo vivente si mantiene ad un basso livello di entropia in quanto assorbe continuamente, attraverso i composti organici strutturalmente ordinati, cibo con cui gli esseri viventi si nutrono, ordine dall’ambiente (entropia negativa). Dopo essere stati utilizzati, questi composti vengono restituiti all’esterno in forma degradata ma comunque utilizzabile da altri esseri.
Come ebbe a sottolineare un altro nome illustre della Fisica, Ludwig Boltzmann, uno che di entropia se ne intendeva: “La lotta generale per l’esistenza degli esseri viventi non è una lotta per l’energia, ma è una lotta per l’entropia.”
Terminata questa breve, ma necessaria, divagazione nella fisica, torniamo al lavoro di Suzman. L’antropologo, in accordo con quanto appena visto, ci dice che la storia dell’evoluzione della vita sulla terra non è altro che la storia di come ogni forma vivente abbia avuto successo nel mettere in atto strategie per accaparrarsi entropia negativa dall’ambiente. Per il ricercatore, sulla terra hanno potuto svilupparsi forme di vita sempre più complesse “perché dissipano energia termica in modo più efficiente rispetto alle forme inorganiche“. L’impulso a trasferire energia è insito negli esseri viventi a livello molecolare. In questo, l’essere umano è stato particolarmente abile. Piuttosto che specializzarsi nello sfruttare un determinato contesto, il bipede umano ha adottato una strategia generalista che è andato affinando sempre di più nel corso della sua evoluzione. Il grande balzo in avanti poi, quello che Suzman chiama la prima grande rivoluzione energetica, si è avuto con la domesticazione del fuoco. Come sia avvenuta questa scoperta non lo sapremo mai. Quello che è certo è che grazie all’avvento della cottura dei cibi, gli umani hanno avuto accesso ad una varietà sempre più ampia di nutrienti. Il che ha contribuito in modo determinate alla sua evoluzione. Rispetto a quelli crudi, infatti, i cibi cotti sono più facili da masticare, digerire e assorbire. Senza considerare che alcuni vegetali presenti in natura risultano commestibili per l’uomo solo dopo cottura. Di questa rivoluzione energetica ne portiamo i segni nel nostro corpo. Rispetto ai nostri cugini primati, ad esempio, ci siamo potuti permettere un cervello molto più sviluppato, che nonostante rappresenti solo il 2% della massa corporea, utilizza il 20% del metabolismo basale, contro il 9% consumato dal cervello degli altri primati. In altre parole, secondo una recente ricerca, se un gorilla si ritrovasse un cervello di massa equivalente al 2% di quella corporea, fermo restando il suo regime alimentare, dovrebbe aumentare di 2 ore e 12 minuti il tempo che dedica giornalmente a nutrirsi. Un aggravio importante visto che per alimentarsi impiega già circa 10 ore al giorno. Altri segni importanti li troviamo nell’accorciamento progressivo del nostro intestino (come detto i cibi cotti sono più digeribili e facilmente assimilabili) nonché nel nostro apparato masticatorio (mandibola, riduzione della grandezza dei premolari e molari e tendenza alla riduzione del loro numero).
L’accesso ad un enorme surplus di energia, facendo molta meno fatica per ottenerla, ha messo i nostri avi di fronte ad una scelta obbligata: come trasformare questa energia. Suzman argomenta in merito partendo dall’osservazione di cosa accade in natura. L’osservato speciale è un piccolo abitante pennuto dell’Africa meridionale: il tessitore mascherato. Questo uccello passa un numero impressionante di ore a costruire e poi, dopo pochi giorni, a smontare nidi intricatissimi. Nel corso di una vita ne costruisce a centinaia…e poi li smonta. Il senso di tutto questo? Nessun vantaggio derivante da una qualche selezione naturale. Però, come spiega Suzman il tutto risulta coerente con la legge dell’entropia. In fondo tutti gli organismi viventi spendono semplicemente energia quando questa è disponibile. Anche il nostro tessitore mascherato, a ben vedere, compie questa follia solamente nei periodi dell’anno in cui la disponibilità di cibo è maggiore (talmente tanto abbondante che non dedica neanche tempo alla ricerca del pasto, ma spilluzzica in qua e là mentre raccoglie freneticamente pagliuzze e ramoscelli). Se poi guardiamo all’uomo moderno, dice l’autore: “Molte delle cose su cui gli esseri umani spendono energia, dalla costruzione di grattacieli sempre più grandiosi e appariscenti alle corse di ultra-maratone, sono difficili da conciliare con la capacità riproduttiva o la sopravvivenza. In effetti, molte delle cose che facciamo per spendere energia rischiano di ridurre la durata della nostra vita piuttosto che estenderla“.
D’altra parte, come visto all’inizio, ciò che chiamiamo lavoro è, nella sua forma più elementare, un trasferimento intenzionale di energia, un modo per ridistribuire l’energia assorbita nell’universo.
I nostri antenati, lungi dal vivere in quell’inferno Hobbesiano fatto di violenza e scarsità, una vita “bruta, brutale e breve”, impararono ad accedere a quantità sempre maggiori di energia, soprattutto dedicando sempre minor tempo a questa attività. Quello che emerge dagli studi sulle ultime popolazioni di cacciatori-raccoglitori viventi è che il tempo che veniva dedicato a procurasi il cibo per la sopravvivenza era molto limitato: circa 15 ore la settimana. E il resto? Tempo libero. Un tempo che veniva buttato via in ozio improduttivo? Assolutamente, anzi, l’aumento del tempo libero avrebbe permesso all’uomo di dedicare sempre più energia alle attività sociali e cognitive, fattori che hanno contribuito in modo determinante alla sua evoluzione, soprattutto perché favorirono l’aumento dei neuroni.
Come ebbe a dire, forse con una certa dose di irriverenza, la scrittrice Agatha Christie: “Non credo che la necessità sia la madre delle invenzioni, le invenzioni, a mio parere, nascono direttamente dall’inattività, probabilmente anche dall’ozio, forse addirittura da una certa pigrizia. Per risparmiarci fastidi”.
Che l’essere umano sia stato condannato a lavorare la terra col sudore della propria fronte, ormai lo sappiamo, è storia recente. Per decine di migliaia di anni i nostri predecessori hanno vissuto nell’abbondanza, soprattutto perché per loro la ricchezza coincideva con l’aver sempre a disposizione ciò che era loro strettamente necessario. Come lo sappiamo? Sempre dagli studi su quegli sparuti gruppi che ancora oggi vivono allo stesso modo ai margini del mondo. E l’uomo 4.0? Suzman riporta un esempio un po’ datato ma molto significativo. Negli anni ‘50 del XX secolo i lavoratori di Kellogg’s, che nei decenni precedenti avevano goduto di una settimana lavorativa di 30 ore, chiesero a maggioranza di ritornare ad una settimana lavorativa di 40 ore. Follia? Per Suzman la risposta è chiara: quei lavoratori volevano lavorare di più per guadagnare più soldi in modo da “acquistare più versioni dell’infinito corteo di prodotti di consumo costantemente migliorati che arrivavano sul mercato nell’opulento dopoguerra americano”.
Se guardiamo bene, questa spinta oggi è ancora più forte. Che tutto sia ancora una volta collegato con quell’enorme surplus di energia, chiamata sovralimentazione, di cui l’odierna società occidentale è affetta? Per Suzman non ci sono dubbi, l’essere umano è come gli “uccelli tessitori ben nutriti che l’entropia spinge a compiere lavoro”.
Dopotutto ad oggi siamo ancora lontani dal vedere avverarsi la famosa profezia keynesiana: ovvero la settimana lavorativa di 15 ore (guarda caso un’attività lavorativa pari a quella dei nostri antenati cacciatori-raccoglitori – ma di questo Keynes non era a conoscenza). Nel 1930, John Maynard Keynes profetizzo che l’obiettivo sarebbe stato raggiunto nel XXI secolo, grazie allo sviluppo massiccio della tecnologia. Ed allora, come scrive nelle sue “Prospettive economiche per i nostri nipoti”, l’uomo sarebbe stato messo di fronte ad un’altra questione: “Così, per la prima volta dalla sua creazione, l’uomo si troverà di fronte al suo vero, costante problema: come impiegare la sua libertà dalle cure economiche più pressanti, come impiegare il tempo libero che la scienza e l’interesse composto gli avranno guadagnato, per vivere bene, piacevolmente e con saggezza. ” L’economista però, nonostante tutto, nutriva serie perplessità su questo scenario futuro, perché riteneva che la maggior parte delle persone non fosse brava ad oziare: “Non esiste paese o popolo, a mio avviso che possa guardare senza terrore all’era del tempo libero e dell’abbondanza. Per troppo tempo, infatti, siamo stati allenati a faticare anziché godere”. Quindi? Si sarebbero potuti aprire altri scenari, più problematici, come ben descritto, successivamente, in un passo del romanzo di fantascienza di Ian McEwan, “Macchine con me”: “Potevamo diventare schiavi di un tempo senza prospettive di impiego. E a quel punto? Ci aspettava forse un generale rinascimento, una emancipazione verso l’amore, l’amicizia, la filosofia, le arti e la scienza, l’adorazione della natura, gli sport e i passatempi, la creatività e la ricerca di un significato? Ma non tutti avrebbero prediletto quegli svaghi sofisticati. Anche il crimine e la violenza esercitavano un’attrattiva, come pure la lotta libera a mani nude, la pornografia, il gioco d’azzardo, l’alcol e le droghe, addirittura la noia e la depressione. Non avremmo avuto il controllo delle nostre scelte.”
Ormai l’antropologia non ha più dubbi sul dichiarare che l’uomo moderno non è solo il prodotto del lavoro dei suoi antenati, ma sopratutto del loro tempo libero. Un tempo che fu dedicato alla curiosità, alla sperimentazione, alla ricerca di sempre nuove strategie di integrazione con un ambiente considerato generoso ed abbondante (la natura diventerà matrigna con l’avvento delle società agricole a ritorno posticipata).
In questo senso possiamo considerare le prime forme di vita umana perfettamente integrate nel loro ecosistema ed assolutamente attive nel contribuire con successo alla missione che tutti gli esseri viventi condividono, quali regolatori dell’entropia della biosfera.
Poi la storia ha preso un’altra piega: l’idea di assoggettare la natura al nostro volere.
Un’idea che ha dominato la nostra più recente storia evolutiva e che è a tutt’oggi il mantra principale dell’uomo del XXI secolo. Il risultato? Ci siamo dimenticati dell’entropia…
“C’è una legge inesorabile, la seconda legge della termodinamica, secondo cui in un sistema chiuso l’entropia, cioè il disordine, continua a crescere. Quando costruiamo un manufatto, una casa, una città, creiamo ordine, diminuiamo l’entropia di quel punto. Però, inesorabilmente, esportiamo il disordine da un’altra parte. E infatti, per creare quelle cose, dobbiamo scavare miniere, bruciare combustibile, espellere fumi. In seguito tutto ciò che abbiamo prodotto invecchia, si deteriora, diventa rottame. Accanto alla città, il luogo dell’ordine, cresce così la discarica, il luogo della mescolanza caotica, del disordine. Fino a poco tempo fa questo processo era lento, poteva essere compensato, riparato da meccanismi naturali. Ma con la crescita continua della popolazione, della produzione e dei consumi, procede in modo incontrollato e terrificante.“ (Francesco Alberoni – Valori)
Un processo che abbiamo fatto crescere in modo abnorme e che ci spinge inesorabilmente a correre sempre di più nella speranza di bilanciare un entropia di cui abbiamo perso il controllo? È questo il motivo per cui oggi inseguiamo una sola chimera, quella del lavoro, come unica possibilità per partecipare al grande gioco universale della trasformazione dell’energia? Facciamo attenzione, forse c’è altro. Se il lavoro non è che “l’applicazione di un’energia al conseguimento di un fine determinato”, allora il fine è fondamentale. Niente di nuovo. Già alla fine del ’800 Robert Louis Stevenson si era accorto di questa anomalia: “L’ attività frenetica, a scuola o in università, in chiesa o al mercato, è sintomo di scarsa voglia di vivere. La capacità di stare in ozio implica una disponibilità e un desiderio universale e un forte senso d’identità personale.”
Il cerchio sembra chiudersi. Questa folle corsa dei tempi moderni è il sintomo di una vita che si è andata allontanandosi sempre di più dalla Vita. E’ la manifestazione di una società in cui le identità sono sempre più liquide, plasmabili, effimere, entropiche. I cui desideri si moltiplicano continuamente come virus.
Le abbiamo chiamate conquiste, ma invece non sono altro che l’evidenza che stiamo perdendo la nostra partita con l’entropia.
Nella profezia keynesiana è contenuto anche un monito: ”Saranno solo coloro che sanno tenere viva, e portare a perfezione l’arte stessa della vita, e che non si vendono in cambio dei mezzi di vita, a poter godere dell’abbondanza, quando verrà”. Se verrà…

Mi piace definirmi un ingegnere umanista. Ho una laurea in ingegneria meccanica ad indirizzo gestionale, ma la mia vera passione è l’essere umano, la mia filosofia di vita: “uomo conosci te stesso”. Osservo, studio, sperimento, condivido, perché come disse un tizio: “poter condividere è poesia nella prosa della vita” (S. Freud)





